I sommersi e i salvati di Primo Levi usciva nel 1986. Nel suo saggio Levi, come lui stesso dichiara, non fa opera di storico, né scrive un diario postumo sulle atrocità della Shoah. Preferisce invece porsi delle domande e, con uno straordinario spirito distaccato, provare a trovare delle risposte a quei dubbi che vanno ben oltre il singolo evento storico. Il saggio finisce così per prendere le sembianze di un’analisi a metà strada tra l’antropologia e la psicologia in cui i temi centrali non possono che essere la memoria e la percezione, smascherate da Levi come strumenti fragili e inefficaci. Come può uno strumento così fallibile come la memoria essere l’unico garante che una simile atrocità non venga perpetuata nuovamente? Come possiamo evitare una nuova Shoah se la comprensione della prima è stata così tormentata, tanto che ancora oggi qualcuno cerca di negarla?
In questo articolo analizzeremo, capitolo per capitolo, le argomentazioni di Primo Levi. A ciascuna delle otto parti del saggio è stato dedicato un video e una mappa.
I. La memoria dell’offesa

Nel primo capitolo Levi ci invita a riflettere sulla memoria umana, ma soprattutto sulla sua possibile inattendibilità. Per definirne i limiti si sofferma in particolare sui meccanismi di rievocazione del ricordo da parte della vittima, ma anche dell’oppressore: le loro condizioni non sono ovviamente intercambiabili, ma entrambi sono accumunati da un’analoga ricerca di difesa e di rifugio dal ricordo dell’esperienza traumatica.
Il processo di elaborazione del passato, e quindi di deformazione del ricordo di una colpa commessa da parte degli oppressori, non dovrebbe essere oggetto di una facile ed immediata condanna poiché ad un’attenta analisi rivela una complessità più profonda, strettamente legata alla fragilità della natura e della memoria umana. Levi sottolinea come gli oppressori non abbiano tanto operato una distorsione dei fatti, quanto avrebbero alterato le motivazioni che li avrebbero spinti a compiere quelle atroci azioni. Poiché accettare il ricordo delle azioni compiute potrebbe essere intollerabile, creare una verità di comodo e più confortevole fino ad arrivare anche nella quotidianità a credere alle proprie menzogne pare la via più semplice per alleggerire il senso di colpa e vivere in pace con se stessi.
II. La zona grigia
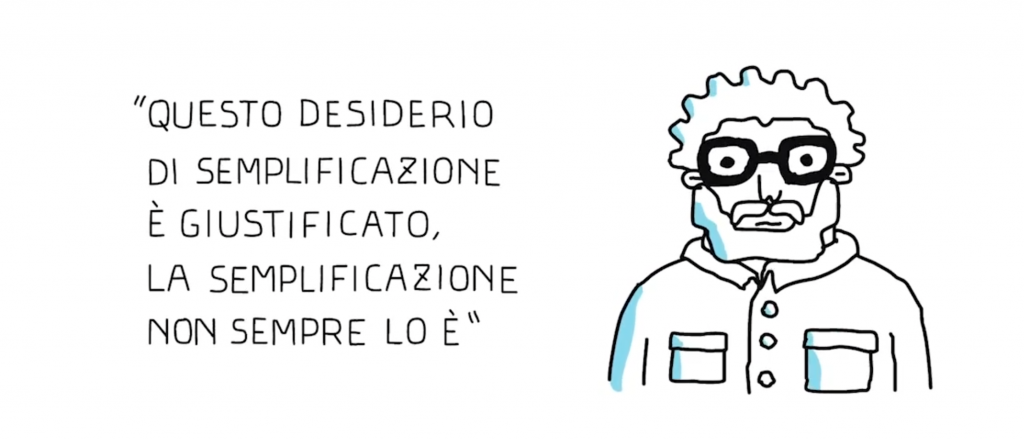
La riflessione sulla complessità del reale continua nel secondo capitolo che si apre con un’attenta considerazione sulla tentazione tipicamente umana di semplificare e quindi di schematizzare la realtà. Secondo Levi una semplificazione non deve mai essere scambiata per la realtà perché essa si presenta sempre più complessa. Estremamente più complessa era quindi la rete dei rapporti umani all’interno dei Lager: Levi ci invita a non lasciarsi travolgere da una facile e immediata suddivisione tra “buoni” e “cattivi”, ma ad esplorare uno spazio particolare, detto «zona grigia», che separa le vittime dai loro oppressori.
In questa «zona grigia» si collocano i cosiddetti prigionieri privilegiati o prigionieri-funzionari che si trovano a collaborare con il potere spinti da diverse motivazioni. Davanti a queste figure secondo Levi è imprudente emettere un giudizio, ma sarebbe più opportuno riflettere su che cosa significa agire in uno stato di costrizione imposto da uno spaventoso potere totalitario come il nazionalsocialismo. A partire da una riflessione generale sulla corruzione messa in atto dal potere e su quali effetti possa avere su persone grigie, ambigue e facili al compromesso, Levi cerca di esplorare più a fondo le motivazioni che spingono questi prigionieri-collaboratori ad agire in un «abisso di malvagità» e di sfumare il giudizio nei loro confronti riportando il caso limite di collaborazione dei Sonderkommandos, le cosiddette Squadre Speciali, e l’ambigua parabola umana di Chaim Rumkowski.
III. La vergogna

Levi introduce questo capitolo smontando innanzitutto uno stereotipo ben definito, consacrato da letteratura, poesia e cinema, ovvero quello che vede nella liberazione dalla schiavitù un momento di pura allegria. Invita a soffermarci invece su un disagio indefinito che ha accompagnato la liberazione dai campi di concentramento: un senso di vergogna o di colpa che ogni superstite ha vissuto in maniera diversa. Vergogna può voler dire riacquistare la consapevolezza di essere stati menomati, dello stile di vita animalesco che si è condotto nel Lager, dei furti commessi, delle omissioni di soccorso e della mancata solidarietà. Dopo la liberazione tuttavia emerge soprattutto la consapevolezza di non aver cercato di opporsi e di resistere al sistema entro cui si era stati assorbiti. Il senso di vergogna, secondo Levi, è soprattutto nei confronti di quei pochi, ma lucidi esempi che hanno avuto la forza e la possibilità di resistere.
Il reduce non può fare a meno di tormentarsi con il pensiero di quello che avrebbe dovuto fare, di essere sopravvissuto a scapito di qualcuno più degno di lui; egli si vede, inoltre, giudicato dalle persone che ascoltano i suoi racconti. Come tutti i “salvati” sarà condannato ad una continua ricerca di una giustificazione soprattutto nei confronti dei “sommersi”.
IV. Comunicare

In contrasto con alcune teorie di moda negli anni ’70, che vedono nell’incomunicabilità una caratteristica della condizione umana tipica della società industriale, Levi dichiara che per l’essere umano è impossibile non comunicare: qualora si neghi la comunicazione, e quindi l’utilizzo del linguaggio, si tratta di un atto di violenza.
L’esperienza dell’incomunicabilità all’interno del Lager è radicale: sapere o non sapere il tedesco poteva essere questione di vita o di morte poiché si crea un vuoto di comunicazione, e quindi di informazione, difficilmente colmabile. Levi racconta che cosa significava vivere all’interno di un contesto come quello del Lager dove per molti la possibilità di comunicazione, e quindi di informazione, era scarsa o nulla. Mentre in un campo come Auschwitz i prigionieri potevano avere la “fortuna” di una sporadica comunicazione con l’esterno e quindi di qualche notizia dal mondo, molte altre realtà erano più sfortunate in quanto totalmente isolate e tormentate solo da orrende notizie locali. Ripensando al particolare accanimento nei confronti degli ebrei nel negare loro la comunicazione con l’esterno e le loro famiglie, Levi riflette infine sulla stretta connessione che si instaura tra comunicazione e libertà.
V. Violenza inutile
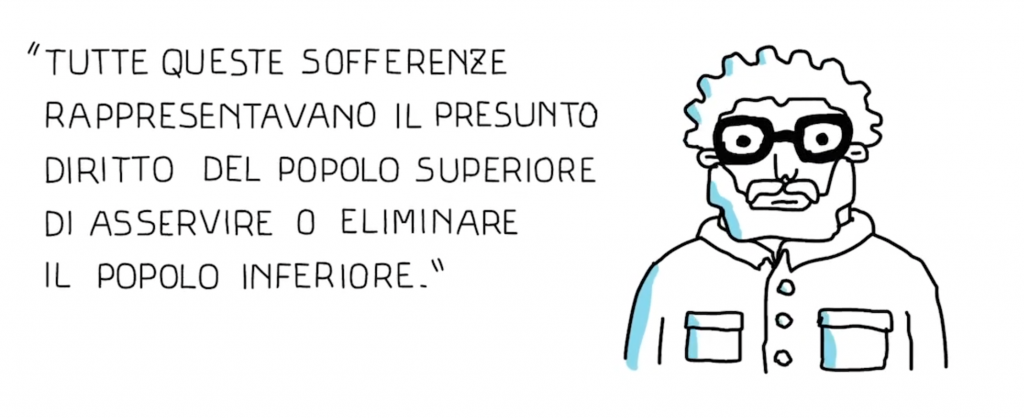
Dopo aver provocatoriamente suggerito che esiste una violenza utile, che si prefigge quindi uno scopo, Levi parte da questa considerazione per riflettere invece sulle inutili violenze perpetrate durante i dodici anni hitleriani. L’azione più crudele, conseguenza logica di un regime disumano, era offendere e privare del pudore i prigionieri non appena entrati nel Lager, dando avvio così al loro processo di trasformazione da umani ad animali. Molte delle costrizioni naziste, ad esempio quella della nudità, parevano non solo inutili, ma offensive nella loro ridondanza: il loro obiettivo era quello di suscitare impotenza e umiliazione negli oppressi. Alcuni ricordi legati a situazioni e a contesti all’interno della vita nel Lager inducono Levi a meditare su quanto la violenza nazista si sia spinta oltre i limiti logici e anche economici, arrivando addirittura a complicare inutilmente il proprio disegno: «il nemico non doveva soltanto morire, ma morire nel tormento.»
Molte delle violenze e dei tormenti inflitti dai nazisti sui prigionieri potevano rivelarsi non solo inutili, ma senza uno scopo apparente o comunque premeditato; questa crudeltà tuttavia è altamente simbolica in quanto secondo le premesse ideologiche del nazismo la vittima, considerata inferiore, deve essere degradata ed umiliata attraverso violenze inutili per alleggerire il peso della colpa dell’oppressore.
VI. L’intellettuale ad Auschwitz

In questo capitolo Levi dichiara di volersi confrontare con un testo ben preciso: un saggio «amaro e gelido» scritto dall’intellettuale e filosofo Hans Mayer, alias Jean Améry, sulla condizione dell’intellettuale ad Auschwitz. Prendendo ispirazione da alcune considerazioni di Améry, Levi si sofferma inizialmente su quelli che potevano essere gli svantaggi per l’intellettuale nel Lager, il quale non educato e abituato al lavoro manuale poteva provare un forte senso di umiliazione. La stessa accettazione della vita e della routine della baracca poteva rivelarsi più complicata e penosa per l’uomo colto. Mestiere e manualità potevano facilitare l’inserimento dell’uomo semplice, mentre cultura, logica e morale non erano strumenti sufficienti per comprendere e decifrare un luogo come il Lager, ma solo un semplice spreco di energie.
Levi tuttavia apre una riflessione sull’utilità della cultura, e quindi sui possibili vantaggi per l’uomo intellettuale: a volte la cultura, che può consistere anche in una reminiscenza scolastica come il “canto di Ulisse”, gli ha permesso di instaurare un legame con il suo passato. La stessa formazione specialistica da chimico non solo lo ha probabilmente salvato, ma un approccio più “naturalistico” nei confronti della realtà gli ha permesso di analizzare e di campionare differenti esemplari di esseri umani, esperienza dalla quale ha potuto gettare le basi della sua identità intellettuale dopo Auschwitz. A partire da un’interessante considerazione di Améry, Levi riflette infine sul rapporto tra la condizione di credente e la vita nel Lager: entrambi concordano sul fatto che la possibilità di confidare e di trovare sostegno in qualcosa, qualunque fosse il loro credo, ha permesso al credente di tollerare con più forza anche i momenti più critici.
VII. Stereotipi

In questo capitolo Levi cerca di analizzare l’esperienza del reduce che decide di raccontare la propria storia. Molto spesso chi racconta deve scontarsi con una serie di domande le quali non solo nel corso del tempo tendono ad aumentare, ma sono sempre più condizionate da una visione stereotipata dell’esperienza storica, alimentata da immagini proposte dalla letteratura e dal cinema, e soprattutto dettata dalla distanza temporale degli eventi.
Alla domanda «perché non siete fuggiti» corrisponde lo stereotipo della fuga come obbligo morale: la libertà è qualcosa che il detenuto deve cercare di ottenere con tutte le sue forze per guarire dalla sua malattia, ovvero la prigionia. Levi riflette su quanto sia difficile in generale per il genere umano riuscire a percepire e a comprendere le esperienze altrui, soprattutto quando sono lontane dal nostro tempo. Sulla questione di una presunta mancata ribellione da parte dei detenuti dei Lager, Levi risponde che innanzitutto qualche tentativo coraggioso era stato fatto, soprattutto con l’obiettivo di voler far conoscere al mondo quanto stava accadendo. Prendendo spunto dalla storia Levi riflette, inoltre, sulla necessità di una guida “meno oppressa” che possa guidare la ribellione: l’immagine dello schiavo che si libera da solo dalle sue catene è pura retorica. L’oppressione estrema, come quella dei Lager, deteriora la forza morale e fisica, rendendo l’uomo incapace di qualunque forma di resistenza.
Levi ci invita infine a fare attenzione e a non lasciarsi condizionare dagli stereotipi soprattutto quando riflettiamo e giudichiamo epoche e luoghi lontani da noi con il nostro metro di giudizio. Chiedersi perché molte famiglie, soprattutto ebree, non sono fuggite “prima” significa per Levi esprimere una concezione anacronistica della storia, che dimentica ed ignora la realtà politica dell’Europa negli anni ’30, e soprattutto le difficoltà che molte persone avrebbero incontrato nell’intraprendere una migrazione fuori dalla propria “patria”.
VIII. Lettere di tedeschi

In quest’ultimo capitolo Levi decide di soffermarsi sulla pubblicazione di Se questo è un uomo e sull’eco che questa testimonianza aveva ottenuto nella Germania Federale. La vicenda della traduzione del testo in lingua tedesca è interessante innanzitutto per il sodalizio nato tra Levi e il suo traduttore: il loro è un sottile lavoro di compromesso, soprattutto sul piano linguistico, che si prefigge l’obiettivo di restaurare la lingua tedesca parlata nel Lager con tutte le sue asprezze. L’edizione tedesca, alla quale Levi fa premettere all’editore una parte della lettera di ringraziamento scritta al suo traduttore, si presenta inoltre come un’importante occasione per cercare di capire la popolazione tedesca. Levi sottolinea come le lettere di maggiore rilevanza per il suo scopo siano quelle ricevute subito dopo la diffusione del libro, scritte da quei membri del popolo tedesco che avevano potuto vedere da vicino quanto stava accedendo.
Levi concede quindi spazio alla lettura di alcune tra le lettere dei suoi corrispondenti tedeschi e riflette soprattutto sulle risposte che gli sono state date sulla questione del “capire” i tedeschi.
Dalla narrazione all’argomentazione: le mappe
I sommersi e i salvati rappresenta lo sforzo ultimo di Primo Levi sull’esperienza nei campi di concentramento. E non solo perché fu l’ultima opera dell’autore torinese prima della morte nel 1987.
Dopo aver offerto la propria testimonianza attraverso una modalità narrativa in Se questo è un uomo, pubblicato nel 1947, in quest’opera Levi supera la precedente prospettiva memorialistica e autobiografica con l’intento condurre una lucida analisi del male e della complessità del reale.
Per rendere merito al doloroso impegno di Levi di passare dal racconto al saggio, dalla testimonianza alla riflessione nitida e strutturata, sono state realizzate otto mappe argomentative (una per ogni capitolo) che, esclusivamente con le parole dell’Autore, schematizzano un ragionare, oggi come sempre, di ineludibile attualità.